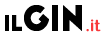Ormai è da tempo che mi capita di leggere articoli dove si dibatte la corretta definizione di gin. Da una parte ci sono i cosiddetti “puristi” che si rifiutano di chiamare gin tutti i distillati che non hanno chiari e netti sentori di ginepro, dall’altro ci sono gli sperimentatori e gli innovatori del settore, che creano prodotti altamente aromatizzati a scapito del ginepro. Il problema nasce dal momento che non c’è una reale definizione condivisa di gin, perché quella diffusa è notevolmente vaga: un distillato con infusione di botaniche tra le quali il ginepro deve essere presente in percentuale maggiore delle altre e con una gradazione alcolica minima del 37%. Si capisce che il margine è molto ampio, infatti la base alcolica di solito è di grano, ma può essere anche ricavata dalla fermentazione di qualsiasi altra cosa; le tecniche di distillazione sono molteplici e tutte egualmente valide; i metodi di infusione o macerazione possono variare; a parte il ginepro che è essenziale, si può utilizzare qualunque altra botanica (sappiamo che esistono gin con l’aragosta, con le formiche rosse e chi più ne ha più ne metta) e il numero di esse può variare notevolmente (ci sono gin con cinquanta botaniche, altri con cinque e altri che addirittura hanno solo il ginepro).
Prova a scrivere più di 3 lettere per vedere i suggerimenti
Il dibattito è aperto: restringere il campo o lasciare libero spazio a tutti? Dipende tutto dalla definizione della parola gin...
E’ giusto chiamare “gin” i distillati dove non predomina il ginepro?
Risulta chiaro che la libertà viene lasciata ai produttori da questa definizione di gin genera la possibilità di dare sfogo alla creatività di ognuno, ma allo stesso tempo crea anche confusione. Will Lowe, master distiller della Cambridge Distillery e spirits educator per il Wine & Spirit Education Trust (WSET), ha dichiarato che questa confusione è generata dalle tante distillerie che si sono allontanate di molto dalle ricette tradizionali facendo sì che i requisiti richiesti dalla UE siano andati persi. “In quanto distiller non posso negare che l’innovazione nei metodi di produzione e nella scelta delle botaniche abbia permesso ai gin di avere identità uniche e che dia ai bevitori di gin la possibilità di attingere da un’ampia scelta. Ma la domanda è: cosa significa davvero “gin” e, soprattutto, cosa significa per i consumatori?”
Lowe non fornisce una sua risposta, ma sottolinea il fatto che, da una parte la crescita e l’innovazione delle distillerie di gin è un qualcosa da festeggiare, dall’altra è sempre più forte l’esigenza di educare i consumatori e gli addetti al settore e di portare chiarezza nella definizione della parola gin. Ciò è proprio la missione de ilGin.it, diffondere la cultura del gin e farlo conoscere al meglio a chiunque desideri approfondire l’argomento. Concordiamo col fatto che il fermento attorno al nostro distillato preferito sia motivo di gioia, ma anche che sia necessario spiegare che cosa si sta bevendo e perché, dare consapevolezza ai bevitori italiani, che già vantano alle spalle una grande tradizione in materia di distillati.
Per quanto riguarda la questione della “perdita del sapore del ginepro” in molti gin moderni, quello che noi sosteniamo è che una delle meraviglie del gin è proprio la sua immensa varietà e quindi, anche se forse alcuni gin possono sembrare “meno gin” di altri, è bello che ognuno possa trovare il brand che più si avvicini ai propri gusti individuali. In questo modo la categoria riesce ad accontentare davvero tutti, apportando vantaggi nel mondo della mixology che sono maggiori rispetto alla confusione creata dalla sua complessità.
Enjoy and God Save the Gin!
Lascia un commento
Conferma