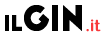Inoltre, io penso che per la categoria del gin l’indicazione geografica non abbia molto senso. Ci sono infatti una miriade di metodi di distillazione ma nessuno di questi è “locale”. I botanici possono essere riforniti da qualunque paese del mondo senza alcuna restrizione se non quelle dettate dagli accordi commerciali tra Paesi e – soprattutto – non vi è un disciplinare rigido. Basti pensare alla stranezza della nomenclatura “London Dry” che indica un metodo di produzione e non che il gin debba essere fatto a Londra.
In aggiunta, che senso ha parlare di “terroir” per un gin? Fa davvero la differenza produrre un gin in UK, in Olanda o in Austria? Certo, in alcuni paesi la “mastery” di alcuni distillatori è inimitabile. Ma basterebbe delocalizzare il distillatore e il suo sapere per ottenere lo stesso prodotto. Certo, in alcuni Paesi si trova una qualità di ginepro superiore, o dei botanici particolari. Ma basterebbe importarli come fanno molti produttori (penso a Bobby’s Schiedam che importa la lemon grass dall’Indonesia, o a N.209 che importa il bergamotto dalla Calabria o al “quintessential” Ophir che si procura le spezie dal nord Africa). Certo, la differenza potrebbe essere data dall’acqua (si pensi al “distilled in England, chilled in Iceland” su cui Martin Miller’s ha costruito il proprio posizionamento distintivo). Ma in tal caso bisognerebbe proteggere l’acqua, non il gin. La domanda che a mio avviso ci dobbiamo porre è la seguente: al consumatore interessa davvero che un gin abbia una indicazione geografica protetta? La risposta a parere di chi scrive è: decisamente NO.
E quale è il rischio di imitazione in un comparto produttivo in cui ogni giorno nasce una nuova etichetta? La gin craze del 21° secolo vede come protagonisti dei produttori che fanno del loro meglio per produrre gin di elevata qualità e con un posizionamento distintivo unico e inimitabile. A qualcuno verrebbe mai in mente di produrre un gin con un’infusione di cetriolo e rosa canina copiando di fatto Hendrick’s? O mettendo more e mirtilli emulando Brockman’s? Beh, a qualcuno è venuto in mente, ma con risultati commerciali del tutto insoddisfacenti. La categoria invece è piena di ottimi esempi di produttori che si sono ricavati un’indicazione geografica non certificata, ma a cui il consumatore fa riferimento come criterio di scelta e di comparazione. Posso citarvi Gin Mare che ha occupato la “nicchia” del posizionamento Mediterraneo. Macaronesian che, come Xoriguer, si è appropriato dell’immaginario di un’isola (Tenerife) senza minimamente preoccuparsi dell’IGT. Monkey 47 che tra le altre (almeno 47) narrazioni di brand ha reso la Schwartzwald un luogo esotico e affascinante e, nell’immaginario del consumatore, luogo di “grandi gin”. Brooklyn che ha costruito un brand facendo leva su un “micro-local” (un quartiere di New York) ma ricco di significati globali, quali il movimento hipster con le sue bretelle, barbe lunghe, camicie a quadri e “scatti fissi”. Ma anche – per citare un esempio locale – a Zu Plun che con Dol Gin si è accaparrato le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco e fiore all’occhiello dell’Italia agli occhi degli stranieri.
Insomma, il locale e il localismo rappresentano ad oggi la principale narrazione di molti brand di successo. Non ci serve di sicuro una IGT. Ci servono dei contesti locali ricchi di storia, di valori, di tradizioni, di storie passate, ma anche contemporanee, che possano affascinare i consumatori e che possano influenzarne la scelta.
E questa è una buona notizia soprattutto per l’emergente ecosistema del gin italiano. Raccontando bene l’Italia nelle narrazioni di marca, forse di fronte alla domanda “Italia o Minorca?” lo stesso consumatore sceglierà l’Italia. Non è cosa comune essere il Paese della “grande Bellezza”. È molto più comune l’IGT.